ROMA. ALLA MAGLIANA CI SI SENTE UN PO’ PIÙ SICURI, GRAZIE ALLA GIUSTIZIA RIPARATIVA
Con il progetto Asylum, la cooperativa Magliana 80 ha proposto un percorso sperimentale di confronto tra comunità e detenuti
22 Febbraio 2019
Di giustizia riparativa negli ultimi anni si parla molto, anche se il tema non è ancora arrivato all’opinione pubblica, che probabilmente fa fatica a metabolizzarlo ed accettarlo, in tempi in cui il problema della sicurezza viene ogni giorno gonfiato e reso prioritario dalla politica e anche dall’informazione. Per questo sono importanti iniziative come quella del CNCA, che il primo febbraio scorso ha organizzato, insieme al Coordinamento Italiano Case Alloggio/AIDS (CICA), il convegno “Mediazione, riparazione e riconciliazione. La comunità di fronte alla sfida della giustizia riparativa”. Per dire, ancora volta, che la via più facile e popolare – quella del “mettiamoli dentro e buttiamo via la chiave” – non è la più efficace, in termini di sicurezza, visto che le misure alternative alla detenzione e i percorsi di accompagnamento all’uscita dal carcere producono un abbassamento della recidiva dal 70% a meno del 20%.
Altrettanto importanti sono le esperienze sul campo, visto che la giustizia riparativa non è solo un’idea, ma anche un insieme di metodi sperimentati, che possono incidere sulla vita delle persone e dei territori. Una di queste esperienza, a Roma, è il progetto Asylum Inclusione Sociale della cooperativa sociale Magliana 80. Finanziato con fondi europei, tramite la regione Lazio, ha per obiettivo finale l’inclusione sociale di detenuti adulti e giovani, è partito a marzo dell’anno scorso, finirà a maggio. Ne parliamo con Germana Cesarano, psicologa, responsabile del progetto.

Che cosa è la giustizia riparativa?
«Ci sono diversi approcci di pensiero. C’è chi considera giustizia riparativa l’insieme delle misure di pena alternative al carcere: messa alla prova, lavori socialmente utili, misure alternative alla detenzione. Più specificamente però – ed è il nostro caso – si parla di giustizia riparativa in riferimento non alla pena, ma alla rottura dei rapporti all’interno della società civile, una rottura che che può crearsi tra chi ha commesso un reato e la vittima, o chi ha genericamente infranto le regole della società civile e la società stessa, che si sente colpita nella sua sicurezza, nella sua integrità, nella sua etica.»
Esistono metodologie per cercare di ricucire questa frattura?
«Sì, le stiamo importando dall’estero, anche se in Italia ci sono sperimentazioni molto interessanti. Puntiamo sulle Conferenze riparative, cioè sull’incontro tra persone che volontariamente si mettono in discussione su quello che hanno fatto, e altre persone che volontariamente portano la loro difficoltà. Insomma, con questo progetto stiamo cercando di costruire l’incontro tra persone che hanno commesso vari reati e il quartiere dove vengono a fare altri percorsi di uscita dal carcere. Molti pensano che la sicurezza sia venuta meno, perché vedono persone che consumano la pena fuori dal carcere, facendo altre attività. Ora hanno la possibilità di incontrarle e di parlare con loro».
In che modo favorite il rientro dei detenuti nella società?
«Da un lato attraverso un corso di formazione, che dà un minimo di know how per potersi vendere sul mercato del lavoro: si tratta di un corso da pizzaiolo. Dall’altro lato il progetto prevede un’attenzione alla storia e al vissuto di ciascuno, quindi anche una rilettura del perché sono arrivati a compiere reati. E poi ci sono le Conferenze riparative, che fanno parte del percorso di presa di coscienza. Spesso le persone che sono state in carcere hanno anche un passato di tossicodipendenza, ma in generale il detenuto tende ad autoassolversi, a dire che la giustizia non è giusta, che quello che ha commesso non è poi così grave… In qualche maniera tendono minimizzare, a non vedere il danno e la frattura con la società».
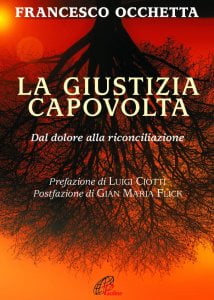
Questo percorso di presa di coscienza non dovrebbe essere fatto in carcere?
«Andrebbe fatto all’inizio della pena, ma la situazione delle carceri in Italia, dal punto di vista delle risorse umane e quindi della possibilità di lavorare con le persone, è problematico. Poiché le carceri sono sovraffollate, il personale è sottodimensionato. Avere un colloquio con un educatore o con uno psicologo è difficile e diventa inevitabile favorire la risposta chimica – quindi attraverso medicinali – al disagio. Non dormi, sei in ansia, stai male? C’è una pastiglia, non un percorso. Anche per questo la giustizia riparativa è più avanti con i minorenni: perché con loro si cerca di evitare la carcerazione, e quindi c’è una cultura, un’esperienza, un’attenzione al percorso di rilettura».
Come sono state scelte le 15 persone che partecipano al progetto?
«I paletti del progetto sono piuttosto rigidi: abbiamo dovuto prendere persone che avessero un fine pena tra i sei e i nove mesi; che non avessero pericolosità sociale; che stessero scontando la pena fuori dal carcere (in affidamento o detenzione domiciliare). Ma mentre per gli affidati è stato molto facile ottenere l’autorizzazione, per gli altri abbiamo dovuto attendere l’autorizzazione del magistrato e questo ha rallentato gli ingressi. E tra l’altro in qualche caso non è stata data».
Come si fa una conferenza riparativa?
«Noi abbiamo cominciando presentando il progetto a tutto il mondo che ci circondava: amministratori del Municipio XI, dove ha sede il progetto, la Consulta del volontariato, i condomini, a cui abbiamo chiesto anche di dirci qual è il danno che pensano di subire a causa della nostra presenza nel palazzo (rumori molesti, fastidio di sentire quello che parla solo di detenzione e reati, vedere la macchina della polizia che tutte le settimane viene a fare i controlli… e c’è una signora arrabbiata perché uno dei nostri utenti si è fidanzato con la figli). Questa è stata la parte più faticosa, se non altro per trovare un orario corretto che vada bene a persone che hanno impegni diversi. Al primo incontro, su cento condomini sono venuti in due, ma al secondo è venuto un numero significativo».

Ci sono stati cambiamenti nei modi di pensare degli abitanti del condominio?
«Sì, direi che le tecniche di mediazione del conflitto hanno funzionato. All’inizio non è stato facile: in fondo chiedevamo loro di rivivere momenti spiacevoli e di accettare un dialogo con persone che, in qualche modo, li avevano provocati. Abbiamo anche compiuto delle azioni che hanno aiutato i cittadini a guardare con occhi diversi la nostra presenza, ad esempio prendendoci cura del piccolo spazio verde che circonda il condominio».
E negli utenti del progetto?
«Anche per loro qualche cosa è cambiato, soprattutto nella presa di coscienza delle proprie responsabilità, ma anche nel modo di guardare gli altri. C’è chi, per fare un esempio, aveva sempre considerato con disprezzo le prostitute che frequentava, ma incontrandole nella sede di Magliana 80 ha capito che anche loro sono persone, con una storia, una sensibilità, dei problemi da affrontare… E soprattutto ha preso coscienza dei propri errori e dei danni che ha fatto».
Con il volontariato come è andata?
«Grazie alla consulta siamo riusciti ad aprire un dialogo con le associazioni, a cui abbiamo spiegato il progetto e tutto il lavoro che stavamo facendo. Il risultato è che alcune si sono rese disponibili per accogliere persone in messa alla prova: un bel passo avanti».
Quindi, in generale?
«Direi che gli abitanti della zona non cambiano strada, quando passano davanti alla comunità ».
Se avete correzioni o suggerimenti da proporci, scrivete a comunicazione@cesv.org








